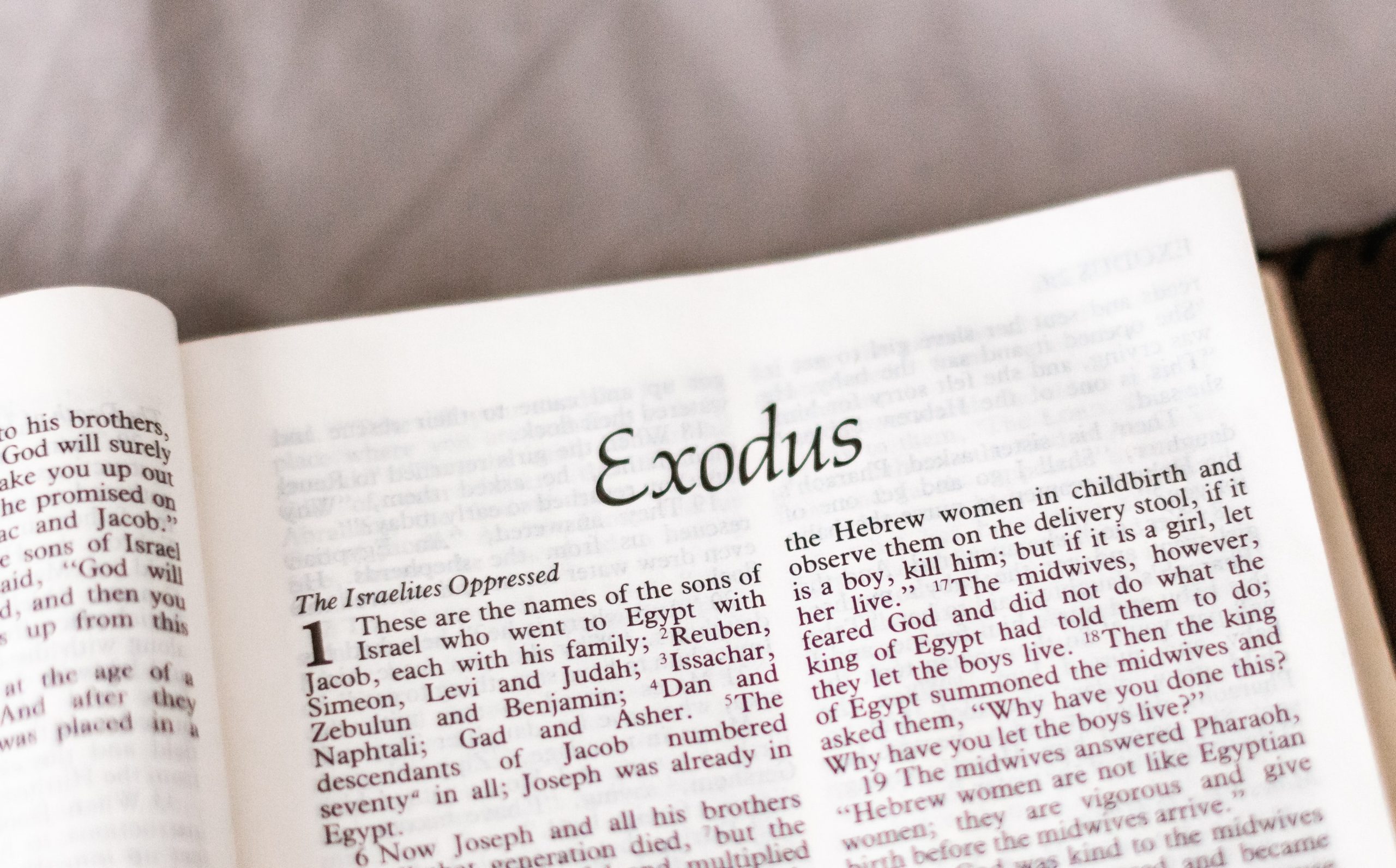Il termine ebraico שָׁמַיִם (shamayim), comunemente tradotto come “cieli,” è ricco di significati e sfumature. Iniziamo analizzandolo dal punto di vista grammaticale: si tratta di un nome che appare nella forma duale, indicando letteralmente “due cieli” o “i cieli” come entità plurale.
Questo suggerisce una visione del mondo radicata nella cosmologia del Vicino Oriente Antico (VOA), dove il concetto di molteplicità nei cieli era una parte integrante della comprensione dell’universo.
L’etimologia di שָׁמַיִם
La radice del termine שָׁמַיִם non è chiara, ma alcuni studiosi suggeriscono che potrebbe essere collegata alla parola אש (esh), che significa “fuoco.” Questa associazione potrebbe riflettere l’aspetto luminoso o infuocato del cielo, visto come la dimora del sole e delle stelle, che appaiono come corpi celesti ardenti.
Tuttavia, altre teorie propongono una connessione con il concetto di “acque” (מַיִם, mayim), suggerendo che i cieli fossero intesi come un oceano celeste sospeso sopra la terra.
Il significato duale del termine
La forma duale di שָׁמַיִם implica un dualismo intrinseco. Nella cosmologia del VOA, il mondo era spesso concepito come una struttura stratificata, con più livelli di cieli sovrapposti. Il dualismo potrebbe riflettere due aspetti del cielo: il cielo visibile, che contiene le nuvole e il firmamento, e il cielo superiore, dimora delle divinità o delle potenze spirituali.
Questo concetto di due cieli era ampiamente diffuso nella mitologia mesopotamica, dove si parlava di cieli più alti, dimora degli dèi, e cieli più bassi, che interagivano con il mondo degli uomini.
La cosmologia biblica e i “due cieli”
Nella Bibbia ebraica, la creazione del cielo è descritta nel primo capitolo della Genesi:
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque, che separi le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento.
Genesi 1,6-7)
Qui, il cielo funge da divisorio tra le acque “di sopra” e quelle “di sotto,” creando una struttura cosmologica che riflette il dualismo suggerito dal termine שָׁמַיִם.
Questa concezione si ricollega a tradizioni antiche che vedevano il cosmo come composto da strati di cielo e terra, con le acque primordiali al di sopra e al di sotto. La distinzione tra il cielo superiore e il cielo inferiore potrebbe quindi essere stata percepita come una distinzione tra la sfera divina e quella terrena, con il firmamento che agisce da barriera tra le due.
Il cielo come dimora di Dio
In alcuni passi biblici, il cielo è descritto come la dimora di Dio:
I cieli dei cieli non possono contenerti
(1 Re 8,27)
Questa espressione rafforza l’idea di una pluralità nei cieli, dove i livelli superiori sarebbero la dimora di Dio, mentre i livelli inferiori potrebbero essere più vicini alla sfera umana. L’idea di più livelli di cieli trova riscontro anche in altre tradizioni religiose del tempo, come quella babilonese, che descrivevano un cosmo con più cieli sovrapposti.
La cosmologia mesopotamica: Enūma Eliš
Il poema babilonese della creazione, l’Enūma Eliš, fornisce un’importante testimonianza della concezione mesopotamica del cosmo. In questo poema, il dio Marduk crea il cielo e la terra dividendo in due il corpo del drago Tiamat, il simbolo delle acque caotiche primordiali.
La parte superiore del corpo diventa il cielo, mentre la parte inferiore forma la terra. Questo atto di separazione stabilisce una divisione tra le acque superiori (quelle sopra il firmamento) e le acque inferiori (quelle sotto la terra), creando così una struttura cosmologica a più strati.
In uno dei testi del poema si legge:
Egli [Marduk] divise in due Tiamat, come un pesce essiccato.
La metà di essa innalzò e ne fece un tetto – il cielo.(Enūma Eliš, Tavola IV, vv. 137-138).
Questa descrizione riflette l’idea di un firmamento che separa i cieli superiori, abitazione degli dèi, dalle acque che si trovano al di sopra del cielo. La presenza di questa divisione è in linea con la concezione del cielo come struttura stratificata.
Un’edizione utilizzata comunemente per lo studio del testo è quella di W.G. Lambert e A.R. Millard, Atra-Ḫasīs: The Babylonian Story of the Flood (Oxford University Press, 1969).
La letteratura ugaritica: il mito di Baal e Yam
Nella mitologia ugaritica, troviamo riferimenti a un cosmo a più livelli, specialmente nei miti che riguardano le lotte tra il dio Baal e Yam (il dio del mare). Nel “Ciclo di Baal,” il monte Saphon, che è considerato la dimora del dio Baal, si erge fino ai cieli superiori.
La distinzione tra la dimora degli dèi sul monte e la sfera terrena suggerisce la presenza di diversi strati celesti, con il monte che funge da ponte tra il mondo terreno e i cieli superiori.
Nel testo si legge:
Baal siede sul monte della sua vittoria,
Saphon, il monte dei cieli che domina.(Il Ciclo di Baal, frammenti ugaritici).
Questi testi sono stati pubblicati in varie raccolte, come quella curata da Mark S. Smith e Wayne T. Pitard in The Ugaritic Baal Cycle (Brill, 2008), che analizza il monte Saphon come luogo centrale nella cosmologia ugaritica.
La cosmologia egiziana
Anche nella cosmologia egiziana, troviamo l’idea di un cielo multiplo. Il cielo era spesso rappresentato come una dea, Nut, il cui corpo arcuato formava la volta celeste. Nut separava il mondo degli dèi, situato al di sopra del suo corpo, dal mondo terreno sottostante:
Nut stese se stessa sopra di te, affinché tu potessi essere un dio per lei, affinché ella potesse rimuovere il tuo veleno… Nut si piega su di te come una mucca si curva sul suo vitello
(Testo delle piramidi 1466a-1466b)
Questa rappresentazione suggerisce una struttura in più strati, dove il cielo agisce come barriera che separa le acque celesti superiori dalle acque terrestri.
La fonte autorevole per lo studio dei “Testi delle Piramidi” è R.O. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, (Oxford University Press, 1969).
Il significato simbolico e spirituale
Il cielo in ebraico biblico non è solo una realtà fisica, ma anche un simbolo di trascendenza e potenza divina. Il dualismo implicito in שָׁמַיִם può quindi essere visto anche come una rappresentazione simbolica della distanza tra l’uomo e Dio, dove il cielo rappresenta l’inaccessibilità della sfera divina, ma al contempo la possibilità di comunicazione con essa, come avviene tramite visioni e profezie.